D.F. Wallace, Il re pallido

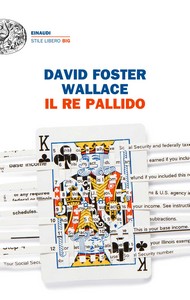 Come è noto, Il Re Pallido è stato pubblicato postumo, perciò non nella versione che David Foster Wallace avrebbe voluto leggessimo. A creare il tomo ha provveduto l’editor e amico di DFW, Michael Pietsch, che ha letto le oltre tremila cartelle lasciate dall’autore, ricavandone le circa cinquecento pagine del romanzo (in italiano, settecento).
Come è noto, Il Re Pallido è stato pubblicato postumo, perciò non nella versione che David Foster Wallace avrebbe voluto leggessimo. A creare il tomo ha provveduto l’editor e amico di DFW, Michael Pietsch, che ha letto le oltre tremila cartelle lasciate dall’autore, ricavandone le circa cinquecento pagine del romanzo (in italiano, settecento).
Leggendo l’opera, che in certi versi è molto distante dalle precedenti creazioni di DWF, ci si chiede continuamente se è così che avrebbe voluto che fosse. DFW rimaneggiava continuamente le sue opere, lo ha detto più volte lui stesso.
Tema del romanzo la noia e l’attenzione, e lo fa scavando in modo morboso, con vertici descrittivi cui Wallace non si era mai spinto. Potenti, poetiche, e interminabili.
“Presta grande attenzione alla cosa più noiosa che trovi (dichiarazioni dei redditi, il golf in televisione) e, a ondate, una noia mai provata ti invaderà finendo quasi per ucciderti. Superala, e sarà come passare dal bianco e nero al colore. Come l’acqua dopo giorni nel deserto. La beatitudine costante in ogni atomo”, si legge.
Ad infiocchettare il tutto, i tecnicismi economico tributari, dato che i personaggi lavorano tutti per l’Agenzia delle Entrate e noi assistiamo al loro meticoloso lavoro.
A sorpresa, dopo un’ottantina di pagine, ancora qualcosa cui DFW non ci aveva abituati: parla l’autore (“nel senso dell’autore vero, l’essere umano vivente con la matita in mano, non una persona narrativa astratta”). Il quale spiega che a vent’anni ha davvero trascorso tredici mesi a fare quel lavoro, da qui tutta la perizia con cui ne tratta, ma d’altro canto, come già fece con il tennis, DFW tratta e in modo quasi ossessivo delle sue passioni, il che garantiva veridicità alle sue storie, inventate di sana pianta.
Wallace voleva descriverci gli esattori come degli eroi, per la loro abnegazione e la loro sopportazione. Anzi, dei supereroi: levitano sulla sedia come fachiri (è il caso un po’ eccessivo di Shane), assorbono milioni di informazioni inutili, dialogano coi fantasmi, parlano con burattini.
L’ordine dato alla successione dei capitoli è rapsodico, alcuni brevissimi accanto ad altri lunghi più di cento pagine – uno dei quali, il 22, in cui l¿agente Chris “Irrelevant” Fogle racconta tutta la sua vita in una meravigliosa opera autonoma.
In molti hanno paragonato questo volume al capolavoro Infinite Jest, a causa forse di mole e della profondità concessa ai personaggi secondari. Come in Infinite Jest c’è spazio anche per capitoli sperimentali, come il capitolo 25, composto di sole 1162 parole impaginate su due colonne, delle quali queste 37 sono un fedele campione: “Chris Acquistipace gira una pagina. David Cusk gira una pagina. Rosellen Brown gira una pagina. Matt Redgate gira una pagina. R. Jarvis Brown gira una pagina. Ann Williams tira leggermente su col naso e gira una pagina“.
Inizialmente, i personaggi sembrano scollegati, poi si scopre che sono tutti dipendenti dell’Agenzia dell’Entrate. Wallace descrive le loro vite prima dell’assunzione all’Agenzia di Peoria (queste sono, probabilmente, le parti più belle del libro, quelle in cui si dispiega la vitalità della scrittura di Wallace e la capacità di esplorare i labirinti della mente, di raccontare sensazioni in cui il lettore si riconosce o di indugiare in situazioni che fanno ridere – si veda su tutti il capitolo del bambino feroce). C’è Sylvanshine sul suo volo pendolare; Lane Dean e la compagna appena rimasta incinta; Chris Fogle, loquace studente di Chicago e i suoi approcci con le droghe; David Cusk, che suda abbondantemente; Leonard Stecyk, che avrà un futuro brillante alla IRS e viene dapprima tratteggiato come odioso idealista ai tempi della scuola elementare; Toni Ware, autodidatta, ingegnosamente vendicativa su larga scala, dalla personalità irreparabilmente distorta da un’infanzia selvaggia e violenta nel sottoproletariato delle case mobili; perfino un David Wallace e la sua biografia simile, ma diversa, da quella dell’autore. Con l’eccezione di Toni Ware, la cui rigida psicopatologia la rende immune al cambiamento, tutti i personaggi diventeranno obbedienti fannulloni una volta entrati nel Servizio.
In un discorso agli studenti del Kenyon College alla cerimonia di laurea nel 2005, Wallace parlò dell’arruolamento come soldati nelle «trincee quotidiane della vita adulta», della «meschina, frustrante merda» che li aspettava là fuori, e del «tran tran triste, noioso e apparentemente senza senso» in cui si sarebbero presto trovati immersi. Criticò l’egocentrismo tendente al solipsismo, e asserì che il valore di una formazione umanistica sta nel fornire i mezzi per scappare. Scappare è avere un’attenzione metodica verso i dettagli meno evidenti delle nostre esistenze.
L’abilità e la raffinatezza intellettuale di Wallace si sono sempre intrecciate con una franchezza morale e sociale dal candore quasi infantile, che è una parte cruciale della sua narrativa. Questo atteggiamento si rileva nel romanzo quando Wallace si sofferma sui mutamenti sociali avvenuti in America a partire dagli anni Sessanta, con l’imposizione del modello consumistico, dell’alienazione e dell’individualismo, mentre scompare la decadenza del senso civico, e la pubblicità diventa sempre dominante.
La lingua di DFW (e la sensibilità nel toccare i temi meno comuni nel modo più sincero e spesso comico) è il vero motivo per cui si dovrebbe leggere Il Re Pallido. E’ ricca, ma al contempo asciutta. Non c’è nessuno spreco, nonostante l’abbondanza. Il primo capitolo, con la descrizione di un campo, in buona parte un elenco di piante, è abbacinante. Purtroppo è sempre nella lingua che si vede che questa non è e non sarebbe stata la versione finale: ci sono dei cali. Dei momenti in cui il mezzo non è all’altezza. E DFW non avrebbe mai dato alle stampe qualcosa che anche in una minuscola parte non fosse stato eccellente.
David Foster Wallace, The Pale King, Traduzione di Giovanna Granato, Einaudi, pag. 714, € 21
Silvia Tozzi
D.F. Wallace, DF Wallace, Einaudi, Il re pallido, letteratura, martelive, martemagazine, Recensioni, Silvia Tozzi