Il Punto Omega e il mito della caverna

[TEATRO/ARTI VISIVE]
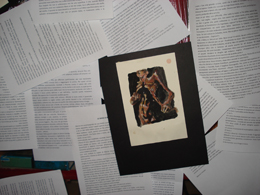 ROMA- Nella religione nazionale, e non ci riferiamo al dio Denaro, quel che conta è l’ortodossia rispetto ad un testo sacro, che tutti conoscono ed intorno al quale proliferano interpretazioni come cerchi concentrici. Nella parti-colare espressione dell’Arte che si è andata manifestando il 4 e 5 febbraio 2011 al Cine-Teatro di via Valsolda 177…
ROMA- Nella religione nazionale, e non ci riferiamo al dio Denaro, quel che conta è l’ortodossia rispetto ad un testo sacro, che tutti conoscono ed intorno al quale proliferano interpretazioni come cerchi concentrici. Nella parti-colare espressione dell’Arte che si è andata manifestando il 4 e 5 febbraio 2011 al Cine-Teatro di via Valsolda 177…
…a Roma, sotto l’egida dell’associazione Agit Art, quel che funge da fulcro attorno al quale si avvolgono le disposizioni dei performers, è un testo ugualmente sacro, ma non scritto.
Un testo la cui sacralità peraltro si origina dalla universalità del messaggio, che parla all’uomo del presente spingendolo a fargli assumere la giusta forma, la giusta identità collettiva, quella che potrebbe essere l’habitus mentale e sociale dell’Uomo del futuro. Il “discorso” messo in scena col titolo di Punto Omega è analogico, nel senso che si propaga per analogie: i due attori hanno lavorato su un arcipelago di testi, a partire (forse) da Theodore Sturgeon, uno dei maestri della “vecchia guardia” della fantascienza, e seguendo lo spirito di un suo romanzo intitolato Più che umano, ma anche alcuni racconti, tra cui La danza del cactus e I figli dei commedianti, sono arrivati a metterli in relazione tra loro e con Ignazio Silone, Celestino V e Bonifacio VIII, includendo anche Teilhard De Chardin, il filosofo-gesuita che teorizzò la noosfera e un evoluzionismo neo-umanista che portasse sia la materia che lo spirito verso il Punto Omega. Una galassia di riferimenti che non hanno un’attinenza stretta in senso filologico, eppure fungono da ispirazione unitaria, che converge, per altro verso, con la metodologia, anzi forse dovremmo dire con l’euristica, dei due attori/performer, l’iraniano Hossein Taheri e il romano Antonio Bilo Canella. Fermo restando  però il lungo processo di assimilazione delle fonti, va specificato con chiarezza che i due continuano anche in scena a ricercare e scoprire quello che presentano, che infatti è il frutto di un’improvvisazione spinta a livelli in cui il concetto stesso di performance di-venta “frastornante”, deve piuttosto essere sostituito dal termine “performAzione”, che indica un’ azione colta nel suo farsi, mentre prende forma, e che non ha come obiettivo una forma testuale definita, perché dopo aver passato la fase di “fagocitazione” dei testi ed aver dato luogo agli accadimenti “onirici” che si sviluppano in forma di interazione sulla scena, ogni riscrittura costituirebbe solo una noiosa rivisitazione dell’evento unico ed irripetibile dispiegatosi davanti agli occhi degli spettatori, anch’essi presenti come ulteriore input.
però il lungo processo di assimilazione delle fonti, va specificato con chiarezza che i due continuano anche in scena a ricercare e scoprire quello che presentano, che infatti è il frutto di un’improvvisazione spinta a livelli in cui il concetto stesso di performance di-venta “frastornante”, deve piuttosto essere sostituito dal termine “performAzione”, che indica un’ azione colta nel suo farsi, mentre prende forma, e che non ha come obiettivo una forma testuale definita, perché dopo aver passato la fase di “fagocitazione” dei testi ed aver dato luogo agli accadimenti “onirici” che si sviluppano in forma di interazione sulla scena, ogni riscrittura costituirebbe solo una noiosa rivisitazione dell’evento unico ed irripetibile dispiegatosi davanti agli occhi degli spettatori, anch’essi presenti come ulteriore input.
Il terzo performer, poi, quell’ Alessio Fralleone noto al grande pubblico per aver vinto la nona edizione del MArteLive, entra in gioco sia subliminalmente come figura schermata (fin troppo) da una asettica tenda di plastica trasparente, dietro cui dipinge dal vivo una sorta di “murale” cosmico, e sia poi, quando l’azione drammaturgica s’è conclusa, come autore “primitivista” dotato di una forza “ulteriore” che gli ha permesso, in quel “fuori campo” a lui riservato, di compiere l’unica, finale, rivelazione di senso di cui resti qualcosa di materiale, anche se è altrettanto enigmatica, magmatica: l’opera pittorica, al tempo stesso ascrivibile al suo stile riconoscibilissimo e tuttavia “forzata” dall’immedesimazione continuata, e ricettiva all’estremo, di tutte le suggestioni derivate dalla “situazione”: l’azione degli attori, i concetti, la spiritualità, l’onda emotiva di ritorno che promana dagli spettatori.
 Ma torniamo ai concetti-chiave di questo progetto: il tentativo di ricostruire uno stato di puerilità, di “puer eternus”, riflette l’immagine sturgeoniana di un’umanità sopravvissuta a se stessa, capace di fondersi telepaticamente in una nuova entità, potente e ambigua. L’aspetto della “fanciullezza scenica” degli attori, il rimanere fanciulli in scena, sorprendersi, sorprendere, non sapere esattamente cosa succederà “agli estremi del teatro”, si mette da solo in relazione con la ricerca borderline di una forza altra, con cui si entra in contatto solo alterando la propria identità in direzione di un futuro visionario, e infatti l’umanità residuale descritta da Sturgeon, composta da bambini, vagabondi, minorati mentali, emarginati riesce a connettersi così come si connettono miliardi di cellule a formare un singolo uomo o miliardi di neuroni a formare un unico cervello con una coscienza.
Ma torniamo ai concetti-chiave di questo progetto: il tentativo di ricostruire uno stato di puerilità, di “puer eternus”, riflette l’immagine sturgeoniana di un’umanità sopravvissuta a se stessa, capace di fondersi telepaticamente in una nuova entità, potente e ambigua. L’aspetto della “fanciullezza scenica” degli attori, il rimanere fanciulli in scena, sorprendersi, sorprendere, non sapere esattamente cosa succederà “agli estremi del teatro”, si mette da solo in relazione con la ricerca borderline di una forza altra, con cui si entra in contatto solo alterando la propria identità in direzione di un futuro visionario, e infatti l’umanità residuale descritta da Sturgeon, composta da bambini, vagabondi, minorati mentali, emarginati riesce a connettersi così come si connettono miliardi di cellule a formare un singolo uomo o miliardi di neuroni a formare un unico cervello con una coscienza.
De Chardin presentiva che l’umanità, se non rinuncia alla logica in base a cui ha finora vissuto in chiave individualistica, arriverà ad una deflagrazione centrifuga delle identità; se invece trova la via per raccogliersi in un nucleo “Più che umano”, può raggiungere il Punto Omega, grado di consapevolezza suprema e forma gestaltica perfetta dell’umanità, “uomo ottimale”; se si vuole, “superuomo”. Mettendo dunque in discussione la nostra concezione attuale di esseri umani, e collaborando ad uno stadio di abbandono allucinatorio, di fiducia integrale nell’”altro da sé”, si può generare una super-identità che abbia completamente trasceso i conflitti egotici o i pregiudizi sociali. E’ evidente che l’idea rappresentata si fa in questo caso tutt’uno con i modi della sua rappresentazione. Il “gioco sacro” con cui i due attori ed il pittore si offrono, si donano, li pervade di una sensazione di grande benessere, eppure al tempo stesso la dimensione trascendentale che si attiva ha anche un aspetto inquietante, ctonio, terrigno, e ciò trova il suo corrispettivo nella situazione descritta da Sturgeon: un’umanità terminale, in condizioni drammatiche, è costretta ad appellarsi a questa grande risorsa umana finora inesplorata, per raggiungere l’obiettivo di una mega-razza, o meta-razza, verso la quale già oggi stiamo tendendo, al di là dei residui di vecchie mentalità retrograde. Con il melting pot che già adesso stiamo cominciando a sperimentare, nel mondo globalizzato del terzo millennio, il meglio delle diverse civiltà potrebbe portare ad organizzarci secondo ciò che è più congeniale all’uomo, sfruttando la facilità di comunicazione, di spostamento, di scambio.
E a proposito del melting pot, e della contaminazione tra i linguaggi, la stessa disperazione allucinata, la stessa distorsione delle prospettive con cui si è aperto lo spettacolo della serata del 4 febbraio, e che ha gettato nello sgomento alcune giovani spettatrici non aduse a confrontarsi con scenari fantascientifici apo-calittici e con esseri umani residuali, poi trascolora in altri momenti in cui l’ironia, e perfino il trash nostrano, si alternano al misticismo stellare e alla deriva psicanalitica. I due protagonisti, infatti, sono due sopravvissuti che rivedono continuamente i loro ruoli di giovane malato, padre premuroso e madre immaginaria, giun-gendo, in questo tourbillon, a interpretare tutte le possibilità umane, a sollevarsi verso l’indicibile e poi tor-nare al punto di partenza ribaltato da una maschera binaria, nella consapevolezza avanzata che è possibile tanto avanzare verso un sublime che spaventa, quanto precipitare verso un’estinzione che faccia trovare pace alle tante autoreferenzialità individuali.
Gli stessi attori, che si definiscono “due favolosi idioti” in omaggio al racconto di Sturgeon che funse da base allo scrittore americano per realizzare “Più che umano”, si divertono in senso etimologico, come pazzi che si distolgono dalla realtà sì, ma quella del teatro borghese, e la loro fisicità, che, volta altrove, esplode sia il meglio che il peggio delle inclinazioni umane, si rivela come il risultato di un enorme affiatamento, che fa sì che uno di loro possa salire in piedi sul ventre dell’altro o tentare amorevolmente di soffocarlo senza creargli danni permanenti. L’energia che si sviluppa tuttavia non può mai essere competitiva, ma si consuma nel segno di una comunione anche col pubblico, trasformato in “assemblea dei fedeli”.
Se è vero, com’è vero, che ai due attori non interessa intessere una storia orizzontale razionale, cioè parlare seguendo un canovaccio piuttosto predeterminato e rigido, come mediamente il teatro borghese fa, è altret-tanto vero che l’apparizione di Alessio Fralleone, al termine dell’azione a due, assume, secondo noi, come già prima abbiamo accennato, il valore di una meta-performance nella performance, ovvero proprio quella ri-scrittura (per immagini, però) che a quest’opera teatrale così pregnante e delicata sarebbe altrimenti man-cata, la trascrizione in stato di trance autoimposta e ultrasoggettiva, di uno spettatore non partecipante ma a-gente, che proietta le sue percezioni sullo sfondo della coscienza di tutti i presenti, un po’ come se fosse uno dei prigionieri del notorio “mito della caverna” di Platone, intento però a dipingersi da sé i suoi valori di riferi-mento, e come se gli spettatori fossero i prigionieri della caverna finalmente abilitati a vedere, cioè ricon-ciliati, sia con la realtà vera di questo futuro “ottimale”, sia con la grezza apparenza delle nostre imperfette ma toccanti ricostruzioni. E’ la coscienza ancora vetero-umana che si esprime, pittura rupestre, antropologia culturale allo stato espressionista dell’urgenza corporale, che si confronta con il medium della narrazione teatrale a tutto tondo, ma proiettata verso un futuro ancora insustanziale, ma di cui gli spettatori colgono il senso appunto guardando non-mediatamente gli astri splendenti di questa nuova conoscenza.
La conoscenza raggiunta dal fisico Frank Tipler, che “riscrive” l’idea del Big Crunch ipotizzando che l’universo si stringa in uno spazio circoscritto e si contragga all’infinito, per rigenerarsi così, al Punto Omega, con energia sempre nuova senza morire mai, come ricorda Fralleone stesso.
L’immedesimazione nell’impegnativo “gioco” non ha risparmiato neanche coloro che di norma verrebbero chiamati i tecnici-audio e delle luci, che sono stati definiti “artisti esterni”, proprio perché sono stati chiamati a seguire un percorso che richiede grande disciplina ed intuizione empatica. Il coinvolgimento di Christian Muela, ormai noto suonatore di didjeridoo con un suo seguito, è stato,  per quanto abbiamo visto, meno intenso, eppure anch’esso, in attesa di una sua possibile (probabile? auspicabile?) integrazione più stretta nello spettacolo, ci è sembrata sufficientemente mirata, perché il musicista durante il lungo aperitivo che ha preceduto lo show, ha fornito gli affascinati presenti di un sottofondo di suoni da “world music” quanto mai appropriati, perché possono sia preludere a manifestazioni tribali di un nuovo medioevo post-nucleare, sia alludere a neo-tribalismi urbani e suburbani, sia semplicemente riportare alla coesione degli aborigeni australiani (da cui lo strumento è stato scoperto) nei loro villaggi, unità sociali ben più ricche di solidarietà e armonia degli agglomerati convulsi di cemento e metallo su ruote in cui ci vantiamo di abitare.
per quanto abbiamo visto, meno intenso, eppure anch’esso, in attesa di una sua possibile (probabile? auspicabile?) integrazione più stretta nello spettacolo, ci è sembrata sufficientemente mirata, perché il musicista durante il lungo aperitivo che ha preceduto lo show, ha fornito gli affascinati presenti di un sottofondo di suoni da “world music” quanto mai appropriati, perché possono sia preludere a manifestazioni tribali di un nuovo medioevo post-nucleare, sia alludere a neo-tribalismi urbani e suburbani, sia semplicemente riportare alla coesione degli aborigeni australiani (da cui lo strumento è stato scoperto) nei loro villaggi, unità sociali ben più ricche di solidarietà e armonia degli agglomerati convulsi di cemento e metallo su ruote in cui ci vantiamo di abitare.
Muela, il cui padre proviene dallo Zaire, ha soffiato nel lungo ramo cavo, oltre al suo fiato sia l’onomatopea d’un trillo mimato, sia il lamento d’un corno inglese, tanto il sordo brontolìo d’uno sciamano di Haiti dopo il terremoto, quanto le invocazioni pseudo-africane di un drugo alla Lebowski, e forse anche i bruciori di stomaco d’un satrapo della Tessaglia, ed i suoi ritmi ansanti e trascinanti sembravano anche avanzamenti d’un pensiero beat nel traffico d’un Mexico City Blues (di Kerouac), ed i suoni con la bocca infatti, come ci ha confermato lo stesso Muela, si chiamano effetti da Big Box, una scatola in cui si può trovare di tutto, comprese le ritualità sessuali chic che Kubrick ha elegantemente visualizzato col suo Eyes Wide Shut (ripensate alla colonna sonora di alcune scene) e che qualcun altro sta volgarizzando sul versante della sciatteria istituzionale.
I due attori di Punto Omega si ricollegano, nella loro prassi scenica, agli attori antichi, “che andavano inva-sati dietro un carro pieno di gente che beveva vino e ad un certo punto impazzivano, saltavano sul carro e cominciavano a raccontare di miti, di Dioniso, ecc…” e al contempo, secondo la logica del sincretismo antro-pologico culturale, si sentono, in questa epoca, “attori del futuro”. Del resto, a proposito della dimensione dell’improvvisazione, da loro davvero vissuta fino in fondo, Hossein Taheri ha dichiartto: “Il testo, teatral-mente, è da sempre stato un pretesto perché succedesse qualcosa”, e Antonio Bilo Canella ha aggiunto: “A volte, rivedendo i nostri video, a posteriori ci rendiamo conto anche del senso. Ma solo successivamente. Lì per lì è come se vivessimo una reale possessione”. In effetti, questo lavoro va anche al di là della ricerca teatrale, si allarga, divenendo bisogno dell’umanità, un po’ per salvarsi da questo tempo e da certa sciatteria.
il7 – Marco Settembre
Alessio Fralleone, Antonio Bilo Canella, arti visive, Christian Muela, Cineteatro Valsolda, Hossein Taheri, Marco Settembre- Il_7, martelive, martemagazine, Punto Omega, roma, teatro