L’utopia, il pecorone, le trivelle, la menopausa

[IL_7 SU…]
 I Servi Disobbedienti non sono lì apposta a provocare la stizza dei signori poco nobili, sono questi ultimi che provano un assurdo raccapriccio per l’orgoglio di uomini capaci di affrontare lucidamente il rapporto tra lavoro e libertà resistendo alle umiliazioni e alle bastonature di quei reazionari che mostrano così il loro vero volto.
I Servi Disobbedienti non sono lì apposta a provocare la stizza dei signori poco nobili, sono questi ultimi che provano un assurdo raccapriccio per l’orgoglio di uomini capaci di affrontare lucidamente il rapporto tra lavoro e libertà resistendo alle umiliazioni e alle bastonature di quei reazionari che mostrano così il loro vero volto.
Il quartetto romano ha un forte legame non con l’ideologia, ma con lo spirito anarchico e con la storia di questa idea e dei lavoratori che, vessati da ingiustizie e sfruttamenti assortiti, ad essa si sono richiamati. A partire dal brano “8 agosto 1956 – Marcinelle”, nel testo di M. Canzoniere ricompare, varcando con forza e discrezione la soglia delle nostre emozioni più profonde, un corteo di anime di uomini comuni ed eroici che hanno militato solo sotto la bandiera della pagnotta, e l’hanno fatto in miniera, dove hanno trovato la morte in una delle tante guerre quotidiane combattute sul lavoro, magari all’estero, dove, per non far aspettare il carbone, bisogna imparar presto le lingue. Dopo l’evocativa introduzione alla fisarmonica, una lenta giostra armonica folk che ci lascia visualizzare stinte foto d’epoca, la circolarità ritmica si scuote trascolorando in una ballata in cui la voce tramanda “il coraggio di amar comunque questa vita che come un treno porta morte o libertà”, e se mille metri di profondità sono tanti, è altrettanto sicuro che “Lacrime e terra nelle unghie e sul viso ai padroni non mostreremo mai”, e questo vale quasi quanto il salario. Il miracolo italiano conobbe una vergogna infamante quando 262 vite, divise tra italiani ed emigranti europei finirono in bare scaglionate, perché “Non sarebbe bello mostrarle al mondo in fila per tre”, stabilì qualcuno. In “No justice, no peace”, l’intro spettrale, con toni lontani ma limpidi di un anthem disperso, concluso da un rombo potente, vale a farci sentire al limite di un mondo trepidante, incagliato in modo struggente tra poesia ed impegno civile, come tutti i “Racconti marginali” di questo CD che viaggia con umiltà sul confine, ma con l’impulso “sacrosanto” di inseguire l’utopia, non un non-luogo, ma un mondo possibile che con la forza dell’immaginazione già intra-vediamo al limite estremo degli orizzonti sociali. No justice, no peace era una scritta su un muro di Genova, su una strada che fu “lavata col sangue”; l’arpeggio acustico rivisita con storicizzata sicurezza la tragedia dei “disobbedienti” del luglio 2001, la nota storia di abusi e violenze, “infiltrati, ideali veri, e non solo anarchici veri”, in lotta contro il neo-liberismo e quello “scudo spaziale” che non può fermare il “groppo alla gola”. Il solco è quello di De Andrè, ed il finale è un lungo ed articolato assolo della fisarmonica a cui si accoda la chitarra elettrica, contrapponendosi entrambe, con questo sodalizio sonoro entusiasmante, alle trame sordide e colpevoli di “chi muove i fili del gioco”. Il groppo alla gola invece si scioglie proprio quando riallaccia quei legami con i piccoli segni e silenzi della Natura che la Storia le sue grandi narrazioni scavalca, ma che danno consistenza al senso panico di una vita piena, in equilibrio sui ritmi del mondo. Ed il respiro di “Fino all’ultimo molo” è proprio quello di chi, musicista o “pescatori di perle” o disperati e morti di peste o “di-sgraziati e forti, fratelli dei cani” (citazione pasoliniana del gruppo), sente la vera vita fluire nonostante il mol-to dolore, “sfogliando il lunario dei giorni” aspettando che “il niente” si condensi in un jazz notturno che con liquidi tremolii pianistici ci inviti a percepire l’esistenza come l’indistinguibile polifonia di diversi arcani canti d’autore, non dissimili da questi che Roberto Petruccio ed i suoi compagni consegnano, con arrangiamenti passionali come un consumato tango, a te, “che ascolti con la tua pietà” le note per “un uccello che non sa volare… una vita che non può più dare”, un “calvario marginale” (“Marginale”).
di anime di uomini comuni ed eroici che hanno militato solo sotto la bandiera della pagnotta, e l’hanno fatto in miniera, dove hanno trovato la morte in una delle tante guerre quotidiane combattute sul lavoro, magari all’estero, dove, per non far aspettare il carbone, bisogna imparar presto le lingue. Dopo l’evocativa introduzione alla fisarmonica, una lenta giostra armonica folk che ci lascia visualizzare stinte foto d’epoca, la circolarità ritmica si scuote trascolorando in una ballata in cui la voce tramanda “il coraggio di amar comunque questa vita che come un treno porta morte o libertà”, e se mille metri di profondità sono tanti, è altrettanto sicuro che “Lacrime e terra nelle unghie e sul viso ai padroni non mostreremo mai”, e questo vale quasi quanto il salario. Il miracolo italiano conobbe una vergogna infamante quando 262 vite, divise tra italiani ed emigranti europei finirono in bare scaglionate, perché “Non sarebbe bello mostrarle al mondo in fila per tre”, stabilì qualcuno. In “No justice, no peace”, l’intro spettrale, con toni lontani ma limpidi di un anthem disperso, concluso da un rombo potente, vale a farci sentire al limite di un mondo trepidante, incagliato in modo struggente tra poesia ed impegno civile, come tutti i “Racconti marginali” di questo CD che viaggia con umiltà sul confine, ma con l’impulso “sacrosanto” di inseguire l’utopia, non un non-luogo, ma un mondo possibile che con la forza dell’immaginazione già intra-vediamo al limite estremo degli orizzonti sociali. No justice, no peace era una scritta su un muro di Genova, su una strada che fu “lavata col sangue”; l’arpeggio acustico rivisita con storicizzata sicurezza la tragedia dei “disobbedienti” del luglio 2001, la nota storia di abusi e violenze, “infiltrati, ideali veri, e non solo anarchici veri”, in lotta contro il neo-liberismo e quello “scudo spaziale” che non può fermare il “groppo alla gola”. Il solco è quello di De Andrè, ed il finale è un lungo ed articolato assolo della fisarmonica a cui si accoda la chitarra elettrica, contrapponendosi entrambe, con questo sodalizio sonoro entusiasmante, alle trame sordide e colpevoli di “chi muove i fili del gioco”. Il groppo alla gola invece si scioglie proprio quando riallaccia quei legami con i piccoli segni e silenzi della Natura che la Storia le sue grandi narrazioni scavalca, ma che danno consistenza al senso panico di una vita piena, in equilibrio sui ritmi del mondo. Ed il respiro di “Fino all’ultimo molo” è proprio quello di chi, musicista o “pescatori di perle” o disperati e morti di peste o “di-sgraziati e forti, fratelli dei cani” (citazione pasoliniana del gruppo), sente la vera vita fluire nonostante il mol-to dolore, “sfogliando il lunario dei giorni” aspettando che “il niente” si condensi in un jazz notturno che con liquidi tremolii pianistici ci inviti a percepire l’esistenza come l’indistinguibile polifonia di diversi arcani canti d’autore, non dissimili da questi che Roberto Petruccio ed i suoi compagni consegnano, con arrangiamenti passionali come un consumato tango, a te, “che ascolti con la tua pietà” le note per “un uccello che non sa volare… una vita che non può più dare”, un “calvario marginale” (“Marginale”).
 I Trioraro potrebbero rappresentare un’eccezione nel panorama della musica indipendente italiana del Centro-Sud se non fossero invece una vera e propria rarità: partendo da una serie di incontri fortuiti e fortunati si costituiscono come quartetto in parte russo, ma poi perdono l’incantevole sax post-sovietico dell’ amico Anatyolie Albina e rimangono un trio costretto a sopravvivere (ma bene) anche alla mancanza di un clavicembalo e di un controfagotto. Il risultato è qualcosa che “Dondola il mondo”, un jazz purissimo, delicato e ondeggiante su interventi misurati di sax ma anche di clarinetto (frutto della prima formmazione, evidentemente) che soffiano insieme le parole ispirate di un testo intriso della sognante serenità d’un mondo ral-lentato. “Come hai fatto a inventare le foglie più verdi del libro sul bosco incantato? Come hai fatto a sapere la voglia che ho di poterti parlare ed abbracciare? Come puoi anticipare ogni brivido che sento e poi meravigliarti quando ti ringrazio perché accogli il mio lamento?” “Come se” si avvale invece di una più fitta trama percussiva e chitarristica, un ruminio incessante, un arzigogolo inquieto, assecondato e approfondito da un basso elastico e formicolante, il giusto sostrato per un monologo interessante, metaforico, “Credo che sia una mia distrazione calcare su di un piano reale… Le tue ricorrenti mosse affrettate sulle pagine dimenti-cate”, riflessioni che, prima che si facciano pesanti o intrusive, vanno snocciolate in velocità per disperdere le carte del mazzo prima che lei azzardi la giocata vincente scompaginando degli schemi già incerti: “come se le trame dei tuoi giochi, come se mi aprissero gli occhi, come se non sentissi il peso di quello che ho preso…” La voce è matura, discute in musica con malcelata lucidità, al netto della poesia, e anche la chitarra smozzica la vivacità intellettuale con una disinvoltura che non è nervosetta, ma lancia il concetto e poi tira via la mano, cioè la melodia dal tessuto, creando manualetti pratici di filosofia funky, sbrigativa nei modi ma non nelle energie che dedica ad un’idea di coppia problematica e chiacchierina. “Live con hamburGER” è uno strumentale più irsuto ritmicamente: la batteria inventa ritmi e tempi bizzarri un po’ alla Bill Bruford che cincischia trovate tribali, la chitarra beccheggia e smanetta in libertà, ed il basso traccia un’andatura sot-terranea da gonzo pagato col minimo sindacale, e l’insieme simula le cadenze mentali d’un pony express australiano incaricato di recapitare in moto un pecorone vivo ad un villaggio di aborigeni, e che durante il tragitto cerca di non innamorarsi della bestia ripetendo a mente il manuale di trigoniometria piana intervallato da ricordi dettagliati delle forme di una entreneuse di Sidney. “Nel tuo viaggio” è un pezzo assolutamente sincopato, con la chitarra che crea cappiole ed il basso che brulica in controtempo; c’è un ritornello che im-pedisce all’ascoltatore di accavallarsi le orecchie, ma in realtà era una sofisticazione ben accetta e stimo-lante, specie per chi sbotta: “Scelgo di viaggiare, scelgo di lasciarmi andare”, con un ritmo swing dominato da una voce dall’intonazione più severa, come se non volesse transigere sulla necessità di muoversi per capire chissàcosa su come il mondo si rivolta per colpa dei suoi abitanti, ma questo mamma non lo sa, bisogna dirglielo al telefono, però il segnale nel finale suona libero, perché lei non sente lo squillo essendo impegnata a farsi la sua cultura restando in salotto a guardarsi la TV col volume alto… Il suono di bacchette che ticchettano contro tamburi spazzolati dà inizio a “Vecchia casa”, in cui la perizia strumentale del trio prende un ritmo da bossanova mentre la chitarra descrive l’andirivieni di ricordi e ospiti colorati e trasandati in una casa coinvolta ingiustamente nella ipotetica soundtrack di una commedia italiana di ultima gene-razione, con due immigrati vicini di casa e omosessuali che portano via la fidanzata al protagonista ed il gat-to che buttandosi giù dall’armadio finisce sulla testa di Don Paolo, venuto a casa a fare un predicozzo al fratello del padrone di casa, che all’oratorio prende tutti a pizze!
I Trioraro potrebbero rappresentare un’eccezione nel panorama della musica indipendente italiana del Centro-Sud se non fossero invece una vera e propria rarità: partendo da una serie di incontri fortuiti e fortunati si costituiscono come quartetto in parte russo, ma poi perdono l’incantevole sax post-sovietico dell’ amico Anatyolie Albina e rimangono un trio costretto a sopravvivere (ma bene) anche alla mancanza di un clavicembalo e di un controfagotto. Il risultato è qualcosa che “Dondola il mondo”, un jazz purissimo, delicato e ondeggiante su interventi misurati di sax ma anche di clarinetto (frutto della prima formmazione, evidentemente) che soffiano insieme le parole ispirate di un testo intriso della sognante serenità d’un mondo ral-lentato. “Come hai fatto a inventare le foglie più verdi del libro sul bosco incantato? Come hai fatto a sapere la voglia che ho di poterti parlare ed abbracciare? Come puoi anticipare ogni brivido che sento e poi meravigliarti quando ti ringrazio perché accogli il mio lamento?” “Come se” si avvale invece di una più fitta trama percussiva e chitarristica, un ruminio incessante, un arzigogolo inquieto, assecondato e approfondito da un basso elastico e formicolante, il giusto sostrato per un monologo interessante, metaforico, “Credo che sia una mia distrazione calcare su di un piano reale… Le tue ricorrenti mosse affrettate sulle pagine dimenti-cate”, riflessioni che, prima che si facciano pesanti o intrusive, vanno snocciolate in velocità per disperdere le carte del mazzo prima che lei azzardi la giocata vincente scompaginando degli schemi già incerti: “come se le trame dei tuoi giochi, come se mi aprissero gli occhi, come se non sentissi il peso di quello che ho preso…” La voce è matura, discute in musica con malcelata lucidità, al netto della poesia, e anche la chitarra smozzica la vivacità intellettuale con una disinvoltura che non è nervosetta, ma lancia il concetto e poi tira via la mano, cioè la melodia dal tessuto, creando manualetti pratici di filosofia funky, sbrigativa nei modi ma non nelle energie che dedica ad un’idea di coppia problematica e chiacchierina. “Live con hamburGER” è uno strumentale più irsuto ritmicamente: la batteria inventa ritmi e tempi bizzarri un po’ alla Bill Bruford che cincischia trovate tribali, la chitarra beccheggia e smanetta in libertà, ed il basso traccia un’andatura sot-terranea da gonzo pagato col minimo sindacale, e l’insieme simula le cadenze mentali d’un pony express australiano incaricato di recapitare in moto un pecorone vivo ad un villaggio di aborigeni, e che durante il tragitto cerca di non innamorarsi della bestia ripetendo a mente il manuale di trigoniometria piana intervallato da ricordi dettagliati delle forme di una entreneuse di Sidney. “Nel tuo viaggio” è un pezzo assolutamente sincopato, con la chitarra che crea cappiole ed il basso che brulica in controtempo; c’è un ritornello che im-pedisce all’ascoltatore di accavallarsi le orecchie, ma in realtà era una sofisticazione ben accetta e stimo-lante, specie per chi sbotta: “Scelgo di viaggiare, scelgo di lasciarmi andare”, con un ritmo swing dominato da una voce dall’intonazione più severa, come se non volesse transigere sulla necessità di muoversi per capire chissàcosa su come il mondo si rivolta per colpa dei suoi abitanti, ma questo mamma non lo sa, bisogna dirglielo al telefono, però il segnale nel finale suona libero, perché lei non sente lo squillo essendo impegnata a farsi la sua cultura restando in salotto a guardarsi la TV col volume alto… Il suono di bacchette che ticchettano contro tamburi spazzolati dà inizio a “Vecchia casa”, in cui la perizia strumentale del trio prende un ritmo da bossanova mentre la chitarra descrive l’andirivieni di ricordi e ospiti colorati e trasandati in una casa coinvolta ingiustamente nella ipotetica soundtrack di una commedia italiana di ultima gene-razione, con due immigrati vicini di casa e omosessuali che portano via la fidanzata al protagonista ed il gat-to che buttandosi giù dall’armadio finisce sulla testa di Don Paolo, venuto a casa a fare un predicozzo al fratello del padrone di casa, che all’oratorio prende tutti a pizze!
The Killer Krab si producono con una spavalderia dovuta al loro uso di macchine storte e  calcolatori trulli per dare suoni alle loro visioni musicali, e se questo non lascia spazio a coloro che temono il futuro perché lo immaginano privo di grandi interpreti del liscio romagnolo, poco male: solo i suoni più sintetici potranno so-pravvivere in un mondo gelido che sfida i sentimenti umani a farsi largo anche nei cloni di platino e bakelite! A parte gli scherzi, “My last serenade” è un rock naturalmente rauco di un selvaggio lover che su una base di chitarra ritmica non elettrica si dichiara pronto a salpare, e in un ritornello in cui smentisce la sua fama di sto-ne hearted, afferma di volersi congedare con quest’ultima serenata, un pensiero fin troppo gentile per lui, quindi sospetto. La seconda parte del brano fluisce più free, a partire da un tappeto di tastiere e da una di-storsione che sfugge subito in un assolo di buona velocità, mentre la voce insiste sulla impossibile ricerca della verità su questa tipa dalla testa curva, ed i controcanti appoggiano il finale che vuole essere piro-tecnico, ma non come l’inizio di “Destroyer”, affidato ad una chitarra epica, hard rock all’arrembaggio dei centri di potere tipo il Supermercato Carrefour o il Parlamento del Mulino Bianco. L’inserzione dell’elet-tronica giunge a puntino e ben accetta, in tempi in cui ogni attacco deve essere spalleggiato dall’azione di hacker rasati, e l’atmosfera ne acquista in profondità e dinamica, ma la chitarra solista si guadagna lo spazio più in vista. “Through Myself” si slancia contro se stessa con un assedio massiccio sferrato contro le proprie risorse pippo-mentali; la strofa è più convincente del solito, il casino “it’in my head, it’s in my soul”, come smontarlo? Lo sfondo di synth in modalità “vox humana” rifornisce di un alone mistico questa lotta senza quartiere contro i lati oscuri della verve da rockettaro, e la sezione ritmica sembra mimare questo travaglio triturando il cervello d’un ciclope. “ElektroPunk” è tra i brani più convincenti, col contrappunto “tecnotronik” che a tratti risuona nel buio, mentre il Killer Krab si nutre di veleni sotto forma di virus informatici e sferra agguati in un sobborgo in fiamme in cui le facciate dei prefabbricati sono adorni di teschi di punk traditori e code di somaro; le “fallen bones are in my lyrics” canta l’eroe, e la guerriglia sonora impazza in una struttura dannata, vigorosa e solennemente incazzata. “Paranoid”, la cover dei Black Sabbath è eseguita con concitazione adeguata allo stato mentale di quel tizio che fa imbizzarrire la chitarra sugli accordi di organo pensando che entrambi gli strumenti ce l’abbiano con lui al punto di scatenargli addosso una batteria che tritura anche le trivelle scavatrici che hanno le macine al posto delle ruote!
calcolatori trulli per dare suoni alle loro visioni musicali, e se questo non lascia spazio a coloro che temono il futuro perché lo immaginano privo di grandi interpreti del liscio romagnolo, poco male: solo i suoni più sintetici potranno so-pravvivere in un mondo gelido che sfida i sentimenti umani a farsi largo anche nei cloni di platino e bakelite! A parte gli scherzi, “My last serenade” è un rock naturalmente rauco di un selvaggio lover che su una base di chitarra ritmica non elettrica si dichiara pronto a salpare, e in un ritornello in cui smentisce la sua fama di sto-ne hearted, afferma di volersi congedare con quest’ultima serenata, un pensiero fin troppo gentile per lui, quindi sospetto. La seconda parte del brano fluisce più free, a partire da un tappeto di tastiere e da una di-storsione che sfugge subito in un assolo di buona velocità, mentre la voce insiste sulla impossibile ricerca della verità su questa tipa dalla testa curva, ed i controcanti appoggiano il finale che vuole essere piro-tecnico, ma non come l’inizio di “Destroyer”, affidato ad una chitarra epica, hard rock all’arrembaggio dei centri di potere tipo il Supermercato Carrefour o il Parlamento del Mulino Bianco. L’inserzione dell’elet-tronica giunge a puntino e ben accetta, in tempi in cui ogni attacco deve essere spalleggiato dall’azione di hacker rasati, e l’atmosfera ne acquista in profondità e dinamica, ma la chitarra solista si guadagna lo spazio più in vista. “Through Myself” si slancia contro se stessa con un assedio massiccio sferrato contro le proprie risorse pippo-mentali; la strofa è più convincente del solito, il casino “it’in my head, it’s in my soul”, come smontarlo? Lo sfondo di synth in modalità “vox humana” rifornisce di un alone mistico questa lotta senza quartiere contro i lati oscuri della verve da rockettaro, e la sezione ritmica sembra mimare questo travaglio triturando il cervello d’un ciclope. “ElektroPunk” è tra i brani più convincenti, col contrappunto “tecnotronik” che a tratti risuona nel buio, mentre il Killer Krab si nutre di veleni sotto forma di virus informatici e sferra agguati in un sobborgo in fiamme in cui le facciate dei prefabbricati sono adorni di teschi di punk traditori e code di somaro; le “fallen bones are in my lyrics” canta l’eroe, e la guerriglia sonora impazza in una struttura dannata, vigorosa e solennemente incazzata. “Paranoid”, la cover dei Black Sabbath è eseguita con concitazione adeguata allo stato mentale di quel tizio che fa imbizzarrire la chitarra sugli accordi di organo pensando che entrambi gli strumenti ce l’abbiano con lui al punto di scatenargli addosso una batteria che tritura anche le trivelle scavatrici che hanno le macine al posto delle ruote!
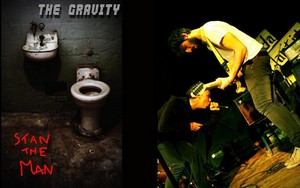 The Gravity hanno il sound giusto, inesorabile come la forza di gravità finchè almeno si tengono i piedi sulla Terra e non ci si lascia infervorare da costruzioni sonore che spostano il fulcro dei pensieri verso stranezze immateriali che sembrano galleggiare nello Spazio… del pentagramma. L’indie in questo caso si orienta alla cieca verso il post-punk, perché già in “Monkey Trait” la registrazione, oltre che perfetta, si articola intorno alle sagomature brillanti di una e più chitarre non banali, che intessono catafalchi tagliati a fette! Un botta e risposta, e poi progressioni che dovrebbero dare una rimodellata ai “lineamenti da scimmia”, ma la voce so-lista cruda e diretta sembra farci intendere che se uno è nato scimmia non può morire robot, e se la linea tonale piega verso il menefreghismo verso i soggetti usciti di notte dal bioparco, l’arrangiamento, nella sua aggressività, propone non solo una una appagante densità del ritornello, ma anche una piacevole varietà nelle sezioni geometrizzanti affidate all’iterazione nevrotica delle chitarre. “Stan the man” ha un ritmo più ska, ed una sei corde prima ossessiva nel pattern rock’n’roll foderato d’amianto, che aspetta le narrazioni inconsulte di stampo punk che piovono come grandine, poi preda dell’apertura, con la pausa e la rincorsa del gruppo dei ribelli con il coro ripetuto “Hey! You!..” nei confronti del pusillanime Stan, che non ha pazienza con i suoi due cavalli malati di pellagra, e li usa come prosciutti per innesti da praticare alla sua convivente su sedia a rotelle. “Where are you?” ha un inizio dissonante e gustoso, poi sulla ritmica costante e sottile, si auscultano i battiti elettronici di un cerca-persone con la sirena anti-incendio, un contrappunto che sembra mono tono, nel senso che pare a tono unico, ma invece non lo è, mentre il resto si declina in maniacalità indie che sfociano in una sezione tambureggiata dalla batteria con una lunghissima raffica che entusiasma i grungettoni più raffinati e con la carica a molla. Quando il pezzo riparte, il contrappunto si insinua nella spina dorsale fino al ritrovamento della persona scomparsa in un ricovero per zitelle con gli occhi grossi, dove praticamente se l’era rimorchiate tutte, alla faccia di “Chi l’ha visto?” D’altronde, “It won’t be like this forever”, proprio perché è un brano dal titolo che mette alla prova la sopportazione logica delle fanciulle più inquadrate, può determinare in altre un fatalismo sessuale che spinga a “dare tutto”, specie le scarpe scamosciate, nel terrore che poi il momento non possa più ripetersi; infatti il brano con le sue sonorità più giocose e leggere, da romanticismo del 2030 con un occhio agli anni ’50 del secolo scorso, rischia di accelerare la menopausa, a prenderlo troppo seriamente godendosi il tramonto e non altro. La soluzione è imparare a gestire il plaisir legato all’ identificazione culturale con le posizioni sociali descritte, in un testo, da significante e significato, e farlo soccombere a fronte della jouissance (Roland Barthes) che decostruisce l’impalcatura semiotica in un teatro mutevole di interpretazioni ironiche, tra cui la migliore, in questo caso, è: aspettate la primavera e poi accoppiatevi nei cespugli di Torvaianica!
The Gravity hanno il sound giusto, inesorabile come la forza di gravità finchè almeno si tengono i piedi sulla Terra e non ci si lascia infervorare da costruzioni sonore che spostano il fulcro dei pensieri verso stranezze immateriali che sembrano galleggiare nello Spazio… del pentagramma. L’indie in questo caso si orienta alla cieca verso il post-punk, perché già in “Monkey Trait” la registrazione, oltre che perfetta, si articola intorno alle sagomature brillanti di una e più chitarre non banali, che intessono catafalchi tagliati a fette! Un botta e risposta, e poi progressioni che dovrebbero dare una rimodellata ai “lineamenti da scimmia”, ma la voce so-lista cruda e diretta sembra farci intendere che se uno è nato scimmia non può morire robot, e se la linea tonale piega verso il menefreghismo verso i soggetti usciti di notte dal bioparco, l’arrangiamento, nella sua aggressività, propone non solo una una appagante densità del ritornello, ma anche una piacevole varietà nelle sezioni geometrizzanti affidate all’iterazione nevrotica delle chitarre. “Stan the man” ha un ritmo più ska, ed una sei corde prima ossessiva nel pattern rock’n’roll foderato d’amianto, che aspetta le narrazioni inconsulte di stampo punk che piovono come grandine, poi preda dell’apertura, con la pausa e la rincorsa del gruppo dei ribelli con il coro ripetuto “Hey! You!..” nei confronti del pusillanime Stan, che non ha pazienza con i suoi due cavalli malati di pellagra, e li usa come prosciutti per innesti da praticare alla sua convivente su sedia a rotelle. “Where are you?” ha un inizio dissonante e gustoso, poi sulla ritmica costante e sottile, si auscultano i battiti elettronici di un cerca-persone con la sirena anti-incendio, un contrappunto che sembra mono tono, nel senso che pare a tono unico, ma invece non lo è, mentre il resto si declina in maniacalità indie che sfociano in una sezione tambureggiata dalla batteria con una lunghissima raffica che entusiasma i grungettoni più raffinati e con la carica a molla. Quando il pezzo riparte, il contrappunto si insinua nella spina dorsale fino al ritrovamento della persona scomparsa in un ricovero per zitelle con gli occhi grossi, dove praticamente se l’era rimorchiate tutte, alla faccia di “Chi l’ha visto?” D’altronde, “It won’t be like this forever”, proprio perché è un brano dal titolo che mette alla prova la sopportazione logica delle fanciulle più inquadrate, può determinare in altre un fatalismo sessuale che spinga a “dare tutto”, specie le scarpe scamosciate, nel terrore che poi il momento non possa più ripetersi; infatti il brano con le sue sonorità più giocose e leggere, da romanticismo del 2030 con un occhio agli anni ’50 del secolo scorso, rischia di accelerare la menopausa, a prenderlo troppo seriamente godendosi il tramonto e non altro. La soluzione è imparare a gestire il plaisir legato all’ identificazione culturale con le posizioni sociali descritte, in un testo, da significante e significato, e farlo soccombere a fronte della jouissance (Roland Barthes) che decostruisce l’impalcatura semiotica in un teatro mutevole di interpretazioni ironiche, tra cui la migliore, in questo caso, è: aspettate la primavera e poi accoppiatevi nei cespugli di Torvaianica!
Il_7 – Marco Settembre
Il_7 Marco Settembre, marco Settembre, martelive, martemagazine, musica, Rubrica Il_7 su, Servi Disobbedienti, The Gravity, The Killer Krab, Trioraro