Fast & bulbous, ecco The Boomers!

[IL_7 SU…]
 Dopo uno svezzamento al pianoforte a base di solfeggio e armonia, Alessandro Peana da Alghero, che a stento si era fin lì trattenuto, immaginiamo, dall’imitare Jerry Lee Lewis tambureggiando le note boogie sulla tastiera e scalciando via lo seggiolino, iniziò una nuova fase.
Dopo uno svezzamento al pianoforte a base di solfeggio e armonia, Alessandro Peana da Alghero, che a stento si era fin lì trattenuto, immaginiamo, dall’imitare Jerry Lee Lewis tambureggiando le note boogie sulla tastiera e scalciando via lo seggiolino, iniziò una nuova fase.
Analogamente a quanto accadde al presidente degli studenti e amico di Lewis quando entrambi furono espulsi dalla scuola cattolica, qualcuno, senza sapere cosa aveva intenzione di fare, ha permesso a Peana, vista la sua prorompente passione per il rock, di passare alla chitarra, che, dopo i corsi al Saint Louis College of Music di Roma, sotto il marchio dei The Boomers è stata spadellata e rifritta tra irsute insurrezioni e languori promiscui, fino a permettergli di contribuire pesantemente ad un sound prorompente anche se non sorprendentissimo, fatto di scanzonati accordi “di genere”  esplorati e scandagliati con cura artigianale e anima ciondolante. Ma per evitare che i pezzi di questo esordio gustoso, in puro spirito rock’n’roll (e derivati) siano considerati dei veri e propri “peana” al Rock, va ribadito l’ovvio, e cioè che il progetto dei The Boomers (Marco Marraccini, Alessandro Peana e Fausto Delfini) irrimediabilmente schierati sul punk-rock-blues come se fosse una trincea in movimento da cui scagliare scanzonate boom-hits sarcastiche contro le apparenze mollicce del mondo, è un ottimo lavoro di squadra, che impasta gli stilemi più angry interpretandoli con sincera partecipazione e chiara consapevolezza della storia del rock. Il gruppo, costituitosi nel 2004 ad opera dei due romani, il chitarrista cantante Marraccini e il batterista Delfini, già animatori storici e instancabili della scena punk-rock romana anni ’80-’90, si completò con la cooptazione del giovane chitarrista sardo Peana, trapiantato nella Capitale; e per il momento (a parte le ultime notizie…) se ne stanno così, in trio, fieri di esprimere il loro sano sarcasmo nevrotico senza il basso, sopprattutto dopo che tre bassisti di seguito hanno abbandonato la band, forse perché avevano la pressione troppo… bassa! Il loro primo disco, “Fast and bulbous” (distribuito da “Good-fellas”), ha un titolo, forte dell’inafferrabile agilità eclettica del materiale, che strizza l’occhio soprattutto al blues decostruito di Captain Beefheart, ma forse anche alla pellicola (Fast & furious, ovviamente) dedicata alle supercars, al drifting e ai guazzabugli tra mafia e business, con la consistente variante, però, della dimensione “bulbosa” conosciuta da chi magari non sfugge solo a sicari motorizzati, ma anche da vischiose situazioni familiari o dal conformismo di citrulli pieni di pregiudizi verso gli interscambi esplosivi nati col dialogo urbano tra “bianco” e “nero”. Quello che in effetti una volta appariva come irrappresentabile ora ci circonda, eppure le forme musicali
esplorati e scandagliati con cura artigianale e anima ciondolante. Ma per evitare che i pezzi di questo esordio gustoso, in puro spirito rock’n’roll (e derivati) siano considerati dei veri e propri “peana” al Rock, va ribadito l’ovvio, e cioè che il progetto dei The Boomers (Marco Marraccini, Alessandro Peana e Fausto Delfini) irrimediabilmente schierati sul punk-rock-blues come se fosse una trincea in movimento da cui scagliare scanzonate boom-hits sarcastiche contro le apparenze mollicce del mondo, è un ottimo lavoro di squadra, che impasta gli stilemi più angry interpretandoli con sincera partecipazione e chiara consapevolezza della storia del rock. Il gruppo, costituitosi nel 2004 ad opera dei due romani, il chitarrista cantante Marraccini e il batterista Delfini, già animatori storici e instancabili della scena punk-rock romana anni ’80-’90, si completò con la cooptazione del giovane chitarrista sardo Peana, trapiantato nella Capitale; e per il momento (a parte le ultime notizie…) se ne stanno così, in trio, fieri di esprimere il loro sano sarcasmo nevrotico senza il basso, sopprattutto dopo che tre bassisti di seguito hanno abbandonato la band, forse perché avevano la pressione troppo… bassa! Il loro primo disco, “Fast and bulbous” (distribuito da “Good-fellas”), ha un titolo, forte dell’inafferrabile agilità eclettica del materiale, che strizza l’occhio soprattutto al blues decostruito di Captain Beefheart, ma forse anche alla pellicola (Fast & furious, ovviamente) dedicata alle supercars, al drifting e ai guazzabugli tra mafia e business, con la consistente variante, però, della dimensione “bulbosa” conosciuta da chi magari non sfugge solo a sicari motorizzati, ma anche da vischiose situazioni familiari o dal conformismo di citrulli pieni di pregiudizi verso gli interscambi esplosivi nati col dialogo urbano tra “bianco” e “nero”. Quello che in effetti una volta appariva come irrappresentabile ora ci circonda, eppure le forme musicali  non cessano di interpretare in modo estremamente vivido, come nel caso dei The Boomers, i limiti della realtà quotidiana, e a farlo in questo caso con una tecnica e una chiarezza d’ intenti che non nuoce affatto, come alcuni faciloni potrebbero pensare, alla diretta e fresca virulenza della proposta. Naturalmente la configurazione culturale attuale è vasta, eppure il diffondersi di queste tensioni vitali, sbilanciate più verso il ribellismo che verso la realizzazione di alternative ancora amorfe, sembra il fer-tilizzante più gradito ad un pubblico giovanile che oggi appare in buona parte legato agli stili subculturali più corrosivi. Fausto Delfini infatti ha messo a suo tempo a ferro e fuoco l’ambiente romano con l’hardcore dei Minimal, e Alessandro Peana dal canto suo ha fatto scaturire il CD “Dicono che voi animali non potete immaginare” dalla sua esperienza con l’alternative rock dei Fumo Passivo, già recensiti da noi in altra sede, mentre Marco Marraccini, ex leader degli Overlord, formazione dal valore certificato da una apprezzata discografia e da una corposa attività live giunta fino in Francia, ha avuto un’evoluzione personale paradigmatica: nato nel 1966 ed inizialmente timido e timoroso bambino, fu scosso a nuova vita non tanto dall’ ascolto dei Beatles e di Elton John, ma proprio da Elvis e dal frenetico rock’n’roll di Chuck Berry e di quel Jerry Lee Lewis citato in apertura; il forzato innesto di corde metalliche sulla sua prima chitarra economica lo portò a sperimentare diverse rotture della stessa, in una palestra di istintualità che era l’immediato preludio alla sua infatuazione musicale per Keith Richards e al conseguente investimento economico-affettivo in una Fender Telecaster da cui ancora oggi appare inseparabile. Uscito disgustato da una serie di lezioni sul jazz, sulla strada dell’arricchimento tecnico trovò un’altra fonte di ispirazione nei Ramones (tirata entusiasticamente anche dentro The Boomers), e dopo lo scioglimento degli Overlord e altre vicissitudini, si unì alla band punk toscana Doo Doo Drivers con cui ha realizzato un 45 giri “devastante”. E a parte la condivisibile passione di Marraccini per la science-fiction e le sue mentite spoglie di impegato della pubblica amministrazione – un tratto indubbiamente più “perverso” che non la scontata appartenenza alla working class – il resto della storia appartiene ai The Boomers.
non cessano di interpretare in modo estremamente vivido, come nel caso dei The Boomers, i limiti della realtà quotidiana, e a farlo in questo caso con una tecnica e una chiarezza d’ intenti che non nuoce affatto, come alcuni faciloni potrebbero pensare, alla diretta e fresca virulenza della proposta. Naturalmente la configurazione culturale attuale è vasta, eppure il diffondersi di queste tensioni vitali, sbilanciate più verso il ribellismo che verso la realizzazione di alternative ancora amorfe, sembra il fer-tilizzante più gradito ad un pubblico giovanile che oggi appare in buona parte legato agli stili subculturali più corrosivi. Fausto Delfini infatti ha messo a suo tempo a ferro e fuoco l’ambiente romano con l’hardcore dei Minimal, e Alessandro Peana dal canto suo ha fatto scaturire il CD “Dicono che voi animali non potete immaginare” dalla sua esperienza con l’alternative rock dei Fumo Passivo, già recensiti da noi in altra sede, mentre Marco Marraccini, ex leader degli Overlord, formazione dal valore certificato da una apprezzata discografia e da una corposa attività live giunta fino in Francia, ha avuto un’evoluzione personale paradigmatica: nato nel 1966 ed inizialmente timido e timoroso bambino, fu scosso a nuova vita non tanto dall’ ascolto dei Beatles e di Elton John, ma proprio da Elvis e dal frenetico rock’n’roll di Chuck Berry e di quel Jerry Lee Lewis citato in apertura; il forzato innesto di corde metalliche sulla sua prima chitarra economica lo portò a sperimentare diverse rotture della stessa, in una palestra di istintualità che era l’immediato preludio alla sua infatuazione musicale per Keith Richards e al conseguente investimento economico-affettivo in una Fender Telecaster da cui ancora oggi appare inseparabile. Uscito disgustato da una serie di lezioni sul jazz, sulla strada dell’arricchimento tecnico trovò un’altra fonte di ispirazione nei Ramones (tirata entusiasticamente anche dentro The Boomers), e dopo lo scioglimento degli Overlord e altre vicissitudini, si unì alla band punk toscana Doo Doo Drivers con cui ha realizzato un 45 giri “devastante”. E a parte la condivisibile passione di Marraccini per la science-fiction e le sue mentite spoglie di impegato della pubblica amministrazione – un tratto indubbiamente più “perverso” che non la scontata appartenenza alla working class – il resto della storia appartiene ai The Boomers.
“Antirave” ti si pianta subito in mezzo alla fronte come se volesse scavarsi uno slot, mentre ci si capitombola in auto verso la celebrazione del nichilismo post-tutto, un rave sfrontatamente tronfio nel suo essere privo di messaggi. La narrazione secca di Marraccini ha un tono vagamente metallico, e lo stop and go su cui è costruito il blues-punk sembra lo slang da vecchia guardia che assiste cinicamente impassibile all’andamento prevedibile della seratona dello sballato di turno. La rappresentazione della parabola fomento-strippo-svuotamento non è tragica, ma è abbastanza indifferente da  marcare lo iato tra i rockers con la testa incazzata e antagonista e i corpi-marionetta che la testa se la cancellano proprio, a suon di pillole. Gli intermezzi chitarristici sono sciolti, sfatti nella sovrapposizione delle frasi musicali, e l’assolo, che sale di tono, sgrulla l’amigdala come una vitarella risalita attraverso il midollo, mentre la voce si fa appena gorgogliante nel finale, simulando la soddisfazione per l’ubriacatura spappolante. “Drab life” è più sorniona, con il riff a molla e l’altra chitarra dinoccolata; mantiene in sottotraccia il borbottio cantato, mentre si guarda intorno sfidando l’acriticità della folla con sguardo vitreo. La vita è monotona, drab, se uno è su di giri e non gli basta la prevedibilità di ciò che accade. Se uno invece prende di mira un altro e gli rovina la vita pezzo per pezzo perlomeno ha qualcosa da fare, e tra le cadenze provocatorie lancia le sue illuminazioni: lui è un fottuto benefattore che rivela all’altro la natura troiesca della moglie (trombandosela) e l’ipocrisia dei suoi amici (sputtanandolo) e neanche si limita a questo; praticamente “risolve i problemi” come Winston Wolf di Pulp Fiction. Le due chitarre s’imporporano facendo le bulbose come la faccia paonazza della vittima, e poi si srotolano sinuose sull’asfalto bollente proprio lì dove il povero disgraziato s’è steso, ridotto a un barbone. Ma deve ritenersi fortunato se in questo brano così beffardo qualcuno gli ha “aperto gli occhi” con queste tessiture blues-rock randagie. Queste sono tanto incancrenite nella sezione strumentale che sul finale devono tirare il fiato lasciando spazio ad una strofa ribadita di soppiatto per dire: azz, che gli ho fatto!, e poi si risollevano robusti col coro di compiaciuta perfidia da uomo libero (da legami) e bastardo. “She won’t love me” è rock’n’roll smanettante, loose, senza commenti; sulla vigoria di fondo, il riff si impone reiterato finchè arriva il momento dei colpi picchiati sul serbatoio, e l’arroventamento del volante si fa insopportabile proprio mentre l’atmosfera si congela dato che lei sembra uno stoccafisso e lui non se ne preoccupa minimamente: lei non mi ama, io me ne frego; perfetto così, tutto scorre, la situazione è fluidificata, mero pretesto per una sferragliata d’altri tempi lungo la Route 66. “Life surfer” ha un andamento paranoico non influenzato dal surf rock come ci si aspetterebbe dal titolo, sembra piuttosto un garage/grunge dai toni vocali un po’ depressi, imprevedibile impostazione emotiva di un tipo che si chiede quale sia il problema nel cavalcare le onde o fare la puttana, e dice al suo interlocutore che forse è il caso che mostri i suoi numeri, ma la spiegazione è che lui fa surf nella vita, non ride e non
marcare lo iato tra i rockers con la testa incazzata e antagonista e i corpi-marionetta che la testa se la cancellano proprio, a suon di pillole. Gli intermezzi chitarristici sono sciolti, sfatti nella sovrapposizione delle frasi musicali, e l’assolo, che sale di tono, sgrulla l’amigdala come una vitarella risalita attraverso il midollo, mentre la voce si fa appena gorgogliante nel finale, simulando la soddisfazione per l’ubriacatura spappolante. “Drab life” è più sorniona, con il riff a molla e l’altra chitarra dinoccolata; mantiene in sottotraccia il borbottio cantato, mentre si guarda intorno sfidando l’acriticità della folla con sguardo vitreo. La vita è monotona, drab, se uno è su di giri e non gli basta la prevedibilità di ciò che accade. Se uno invece prende di mira un altro e gli rovina la vita pezzo per pezzo perlomeno ha qualcosa da fare, e tra le cadenze provocatorie lancia le sue illuminazioni: lui è un fottuto benefattore che rivela all’altro la natura troiesca della moglie (trombandosela) e l’ipocrisia dei suoi amici (sputtanandolo) e neanche si limita a questo; praticamente “risolve i problemi” come Winston Wolf di Pulp Fiction. Le due chitarre s’imporporano facendo le bulbose come la faccia paonazza della vittima, e poi si srotolano sinuose sull’asfalto bollente proprio lì dove il povero disgraziato s’è steso, ridotto a un barbone. Ma deve ritenersi fortunato se in questo brano così beffardo qualcuno gli ha “aperto gli occhi” con queste tessiture blues-rock randagie. Queste sono tanto incancrenite nella sezione strumentale che sul finale devono tirare il fiato lasciando spazio ad una strofa ribadita di soppiatto per dire: azz, che gli ho fatto!, e poi si risollevano robusti col coro di compiaciuta perfidia da uomo libero (da legami) e bastardo. “She won’t love me” è rock’n’roll smanettante, loose, senza commenti; sulla vigoria di fondo, il riff si impone reiterato finchè arriva il momento dei colpi picchiati sul serbatoio, e l’arroventamento del volante si fa insopportabile proprio mentre l’atmosfera si congela dato che lei sembra uno stoccafisso e lui non se ne preoccupa minimamente: lei non mi ama, io me ne frego; perfetto così, tutto scorre, la situazione è fluidificata, mero pretesto per una sferragliata d’altri tempi lungo la Route 66. “Life surfer” ha un andamento paranoico non influenzato dal surf rock come ci si aspetterebbe dal titolo, sembra piuttosto un garage/grunge dai toni vocali un po’ depressi, imprevedibile impostazione emotiva di un tipo che si chiede quale sia il problema nel cavalcare le onde o fare la puttana, e dice al suo interlocutore che forse è il caso che mostri i suoi numeri, ma la spiegazione è che lui fa surf nella vita, non ride e non  piange, è a metà tra vivo e morto, ed i suoi acuti sembrano slegati dai suoi pensieri ma non dal filo di distorsione che accompagna il pattern chitarristico all’inizio di un paio di strofe e dopo l’assolo sconcertato da tanta dolente malinconia. Questo precede le sezioni finali svagate e ossessive ed il life surfer si scuote un po’ col conclusivo menefreghismo: “Fuck you all! I say goodbye! Wooo-hooo!”. “No use” è un blues originale, con l’impazienza di fondo ed il riff particolare che molleggia e tira dentro la struttura sincopata, mentre la voce, che sembra trattata, rimanda vagamente ai Red Hot Chili Peppers mentre si fa beffe di chi avrebbe volentieri un rapporto sessuale col cellulare o si compra la macchina perché stufo di quella vecchia e poi si bea del navigatore. Non ci servono le cose fatte di creta, ammonisce il ritornello a due voci, cantilenante e canzonatorio prima del doppio finale, prima masticato dalle due chitarre, poi affidato ad un assolo di fluida abrasività. “White affair” è decisamente stizzoso, con le due chitarre impegolate in un ritmo saltellante, che si squaderna in un ritornello un po’ seventies, così come l’assolo da blues elettrico, che stravacca rabbioso nel finale ruvido e scazzato insieme: lo sporco odio è un affare bianco, se sei nero sei un bersaglio per chi ti ammazza anche solo per gusto, ed è così da 2000 anni, ma non c’è da vantarsene. “War” è un trascinato punk blues disgustato, con le parole che vengono in un flusso che cerca di contrapporsi al mare truculento prodotto dalle guerre; esasperata, la voce raccoglie il suo sdegno e dichiara che si rifiuterebbe di essere un pupazzo con la pistola, non lo farà, non importa che mucchio di quattrini sarà spartito da chi decide la mattanza. Aggirate le retoriche, “I will not do it, man!”, si ricorda che di quelli che non ci lasciano la pelle, qualcuno ne esce con un “mental shock”, noi preferiamo restare con i nostri guai nel tentativo di vivere la nostra vita, di solidi principi, opposti alla grande truffa con una rabbia screziata di blues classico grazie all’intervento dell’armonica da contestazione grezza e salutare. “The conquer man” ha invece un ritmo più incalzante, ma con un’articolazione chitarristica bizzarra che, ripetuta, si pone come riff puntiglioso e dispettoso, che tiene il diagramma della stizza in fibrillazione sotto alla parte vocale a tratti effettata, e invece ferocemente antagonista nel ritornello, a cui, dopo il secondo il passaggio, segue un assolo avvelenato e storto e poi una sezione a impulsi epilettici. Il tutto in un brano contro l’uomo che ha sacrificato tutto
piange, è a metà tra vivo e morto, ed i suoi acuti sembrano slegati dai suoi pensieri ma non dal filo di distorsione che accompagna il pattern chitarristico all’inizio di un paio di strofe e dopo l’assolo sconcertato da tanta dolente malinconia. Questo precede le sezioni finali svagate e ossessive ed il life surfer si scuote un po’ col conclusivo menefreghismo: “Fuck you all! I say goodbye! Wooo-hooo!”. “No use” è un blues originale, con l’impazienza di fondo ed il riff particolare che molleggia e tira dentro la struttura sincopata, mentre la voce, che sembra trattata, rimanda vagamente ai Red Hot Chili Peppers mentre si fa beffe di chi avrebbe volentieri un rapporto sessuale col cellulare o si compra la macchina perché stufo di quella vecchia e poi si bea del navigatore. Non ci servono le cose fatte di creta, ammonisce il ritornello a due voci, cantilenante e canzonatorio prima del doppio finale, prima masticato dalle due chitarre, poi affidato ad un assolo di fluida abrasività. “White affair” è decisamente stizzoso, con le due chitarre impegolate in un ritmo saltellante, che si squaderna in un ritornello un po’ seventies, così come l’assolo da blues elettrico, che stravacca rabbioso nel finale ruvido e scazzato insieme: lo sporco odio è un affare bianco, se sei nero sei un bersaglio per chi ti ammazza anche solo per gusto, ed è così da 2000 anni, ma non c’è da vantarsene. “War” è un trascinato punk blues disgustato, con le parole che vengono in un flusso che cerca di contrapporsi al mare truculento prodotto dalle guerre; esasperata, la voce raccoglie il suo sdegno e dichiara che si rifiuterebbe di essere un pupazzo con la pistola, non lo farà, non importa che mucchio di quattrini sarà spartito da chi decide la mattanza. Aggirate le retoriche, “I will not do it, man!”, si ricorda che di quelli che non ci lasciano la pelle, qualcuno ne esce con un “mental shock”, noi preferiamo restare con i nostri guai nel tentativo di vivere la nostra vita, di solidi principi, opposti alla grande truffa con una rabbia screziata di blues classico grazie all’intervento dell’armonica da contestazione grezza e salutare. “The conquer man” ha invece un ritmo più incalzante, ma con un’articolazione chitarristica bizzarra che, ripetuta, si pone come riff puntiglioso e dispettoso, che tiene il diagramma della stizza in fibrillazione sotto alla parte vocale a tratti effettata, e invece ferocemente antagonista nel ritornello, a cui, dopo il secondo il passaggio, segue un assolo avvelenato e storto e poi una sezione a impulsi epilettici. Il tutto in un brano contro l’uomo che ha sacrificato tutto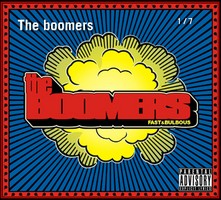 alla sete di conquista creandosi un impero sulla pelle dei suoi “nemici” e ponendosi al di là della “vana giustizia umana”, per poi entrare in politica e consolidare l’impero. Che nome vogliamo dare a quest’”uomo soddisfatto”? “Second coming man” è la pruriginosa autopresentazione di un tale che ogni volta soffre di ejaculatio praecox alla prima botta, per cui lo chiamano “quello della seconda venuta”; anche se può arrivare a quattro tacche, l’essenziale è che la sweet baby di turno gli perdoni la prima. Le percussioni sono un clangore regolare, ed il rock’n’roll è liberato da inibizioni; la chitarra è anche un po’ slide e la frenesia è giustificata dal fatto di lasciare spazio all’assolo dell’armonica gaudente, ma soprattutto dalla necessità di non far correre troppo tempo tra una “passata” e l’altra. “Glad to see you go” (riuscitissima cover del pezzo dei Ramones) sembra l’arbitrario delirio di un killer seriale gasato che pensa di provarci con lei e poi, in un momento di passione, sparare e trarne una gloria nefasta alla Charles Manson: il ritmo è secco, come un punk sporco, col martellante frasario insensato “They’re gonna want my autograph”, e la pericolosa idiozia tracima di gran carriera verso l’autoannullamento ferale e odioso: “Glad to see you go go go go goodbye”. “The end”, coraggiosa, forse azzardata cover del memorabile pezzo dei Doors, ha un avvio aggressivo ordinario, poi si fa riconoscibile, e stupisce la noncuranza street punk con cui il vocalist intona le celebri parole, ad indicare che non esiste nessuna epica drammatica e visionaria neanche nella “fine”, così come non ve n’è traccia in esistenze svilite dalle politiche economiche, dallo sciovinismo delle nazioni, e dal conformismo ipocrita, che rende come minimo un tantino svogliati. L’assolo sembra la marcescente versione di un inno nazionale della alien nation, ed anche il finale è tutto un tirar via imbarbarito e disossato. “Silicone doll” è un bluesone dark e sensuale dominato da una parte che avrebbe forse potuto essere del basso, e infatti affonda nella classica situazione morbosetta da sex on the TV, il desiderio è allo stadio bruto e la pin up sa fare bene i suoi lavoretti davanti al monitor ma l’autentico gonzo decide di aumentare il piacere della simulazione mettendo la testa in un sacchetto di plastica ed ora si fotte al creatore: il pirla, mentre lei veniva, se n’è andato, soffocato! L’assolo è inviperito, ronzante e incuneato dentro il sacchetto di plastica pieno della testa di… cavolo, ma tutto il brano “acchiappa”, corposo nella sua vicinanza pornografica agli standards del genere in veste un po’ alternative. “Fear lab” parte con lo stuzzichìo ritmato della chitarra insolente, e cova in questa forma i ricordi di un’adolescenza contratta, carica di un senso di pigolamento e raccolta di briciole che si protrae fino ad ora con le sue ombre, col ruminio chitarristico, un mantra dedicato al bambino timido che accumulava affronti e non reagiva, lo fa adesso con questo messaggio, quasi spoken word in musica, lanciato con commozione alla generazione successiva, una ferita che raschia l’anima nel crescendo “vero” e nudo, mostrando la primeva ingiustizia, radicalizzata da un assolo finale infibulato nella frustrazione immotivata. Che faccia vergognare i sadici di ogni età!
alla sete di conquista creandosi un impero sulla pelle dei suoi “nemici” e ponendosi al di là della “vana giustizia umana”, per poi entrare in politica e consolidare l’impero. Che nome vogliamo dare a quest’”uomo soddisfatto”? “Second coming man” è la pruriginosa autopresentazione di un tale che ogni volta soffre di ejaculatio praecox alla prima botta, per cui lo chiamano “quello della seconda venuta”; anche se può arrivare a quattro tacche, l’essenziale è che la sweet baby di turno gli perdoni la prima. Le percussioni sono un clangore regolare, ed il rock’n’roll è liberato da inibizioni; la chitarra è anche un po’ slide e la frenesia è giustificata dal fatto di lasciare spazio all’assolo dell’armonica gaudente, ma soprattutto dalla necessità di non far correre troppo tempo tra una “passata” e l’altra. “Glad to see you go” (riuscitissima cover del pezzo dei Ramones) sembra l’arbitrario delirio di un killer seriale gasato che pensa di provarci con lei e poi, in un momento di passione, sparare e trarne una gloria nefasta alla Charles Manson: il ritmo è secco, come un punk sporco, col martellante frasario insensato “They’re gonna want my autograph”, e la pericolosa idiozia tracima di gran carriera verso l’autoannullamento ferale e odioso: “Glad to see you go go go go goodbye”. “The end”, coraggiosa, forse azzardata cover del memorabile pezzo dei Doors, ha un avvio aggressivo ordinario, poi si fa riconoscibile, e stupisce la noncuranza street punk con cui il vocalist intona le celebri parole, ad indicare che non esiste nessuna epica drammatica e visionaria neanche nella “fine”, così come non ve n’è traccia in esistenze svilite dalle politiche economiche, dallo sciovinismo delle nazioni, e dal conformismo ipocrita, che rende come minimo un tantino svogliati. L’assolo sembra la marcescente versione di un inno nazionale della alien nation, ed anche il finale è tutto un tirar via imbarbarito e disossato. “Silicone doll” è un bluesone dark e sensuale dominato da una parte che avrebbe forse potuto essere del basso, e infatti affonda nella classica situazione morbosetta da sex on the TV, il desiderio è allo stadio bruto e la pin up sa fare bene i suoi lavoretti davanti al monitor ma l’autentico gonzo decide di aumentare il piacere della simulazione mettendo la testa in un sacchetto di plastica ed ora si fotte al creatore: il pirla, mentre lei veniva, se n’è andato, soffocato! L’assolo è inviperito, ronzante e incuneato dentro il sacchetto di plastica pieno della testa di… cavolo, ma tutto il brano “acchiappa”, corposo nella sua vicinanza pornografica agli standards del genere in veste un po’ alternative. “Fear lab” parte con lo stuzzichìo ritmato della chitarra insolente, e cova in questa forma i ricordi di un’adolescenza contratta, carica di un senso di pigolamento e raccolta di briciole che si protrae fino ad ora con le sue ombre, col ruminio chitarristico, un mantra dedicato al bambino timido che accumulava affronti e non reagiva, lo fa adesso con questo messaggio, quasi spoken word in musica, lanciato con commozione alla generazione successiva, una ferita che raschia l’anima nel crescendo “vero” e nudo, mostrando la primeva ingiustizia, radicalizzata da un assolo finale infibulato nella frustrazione immotivata. Che faccia vergognare i sadici di ogni età!
Il disco è acquistabile come enhanced CD comprensivo del video di “Antirave” in pongo stop motion (ma ce ne sono anche altri) o scaricabile gratuitamente in mp3 dal sito http://www.boomers.it !
il7 – Marco Settembre
Fast & Bulbous, Il 7 Su, marco Settembre, martelive, martemagazine, The Boomers