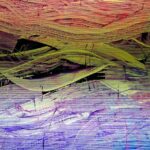PITTURA_ Metafisica di cera, gravidanze isteriche, il becco espressionista

 Irene Salvatori, la cui esperienza è figlia della convinzione, e non viceversa, dipinge con dedizione figure di vaga ascendenza dechirichiana.
Irene Salvatori, la cui esperienza è figlia della convinzione, e non viceversa, dipinge con dedizione figure di vaga ascendenza dechirichiana.
Ma non è affatto certo che si tratti di manichini, piuttosto sembrano umanoidi in crisi di identità, che invece di confrontarsi con scenari neoclassici sottilmente minacciosi con le loro prospettive allungate e piene delle ombre d’un progresso traditore, si nascondono il volto, impegnati a concentrare il flusso delle loro riflessioni usandolo come appiglio malfermo in un buio assoluto in cui riesce a rifulgere solo l’astro isolato, pop-concettuale, di una luce bianca che illumina altre due figure bianche, in silhouette, che si tengono avvinte cercando conforto dal Nulla ingombrante, proiezioni di sé ricorrenti nel ciclo “La vita segreta dell’ombra”. Non è concesso emergere ad altri esseri o oggetti che creino un tessuto de-scrittivo, se non narrativo, la stessa substantia è merce rara, la rarefazione incombe, è quasi un diktat del sistema spersonalizzante che governa la galassia dei rapporti umani post-moderni. L’artista, che ha frequentato l’Accademia a Parigi, ha compiuto studi di iperrealismo a Parigi e a Roma, e si è lasciata raggiungere dall’influenza caravaggesca malgrado la lontananza nel tempo dall’illustrissimo modello, nel dipinto eseguito dal vivo ha disposto gli elementi della composizione in modo che la carnalità di cui solo i suoi umanoidi risultano essere costituiti, sembra calare, anzi colare, dall’alto, come una “liquidità dell’anima”, “tipica” – secondo l’artista – di chi non è perfettamente definito, di chi non ha il carisma personale per confrontarsi con le elites”; a noi sembra invece una dimensione da statue di cera di cui si può essere investiti anche dopo una lunga attesa nel limbo depresso delle apparenze, mentre altri dotati della concretezza di facce di bronzo, senza meriti si conquistano piedistalli instabili pagando volgari tributi, ma qui ci spostiamo sul piano della realtà più opaca, mentre rispetto a questi lavori l’impressione dominante resta quella di una ricerca plastica della luce (proprio caravaggesca?) che insiste sul corpo e al contempo su suggestioni concettuali, negandosi l’ancoraggio di un qualsiasi simbolismo, ed il risultato è una metafisica prosciugata, disadorna, “stilosa” nel suo minimalismo, negli umanoidi plasmabili e nei loro sogni bianco-neri, così sintetici da essere avari, “secchi”, come afferma l’artista, quindi eleganti ma non troppo ricchi di attrattive formali.
In una serata tutta al femminile, quella del 31/5/2011 all’Alpheus, per l’ultima serata delle selezioni regionali del  Marte Live contest, Giulia Fiaschetti con “Solo ciò che è necessario è pesante, solo ciò che pesa ha valore” non ha inteso esaltare i lottatori di sumo o quella ampia percentuale della popolazione americana che è decisamente sovrappeso e si cura con gli hot dogs al miele e senape; no, la Fiaschetti ha voluto affermare il pondus di una donna baciata dal gravame sferoidale d’una maternità che la fa rifulgere scultorea come un insieme di forme plumbee e metafisiche su uno sfondo nero, blu e rosso che si curva nell’ attesa del frutto di questa gravidanza. Quest’ultima sembra quasi una “concrètion” alla Hans Arp, un procedimento naturale basato su forme morbide che solo l’atto umano di dipingere o di partorire può indirizzare verso una forma specifica. E qui da questa solennità energetica e arcana non possiamo che attenderci la messa al mondo di una perfezione concentrica. “Assaporando la dolce leggerezza dell’essere”, l’artista invece contraddice Milan Kundera negando l’insostenibilità della medesima, affondandola piuttosto in una suggestiva aureola di luce in cui la stesura del colore è prodotta in qualche zona, da pennellate a spazzola incrociate, a sfumare, attorno alla figura monumentale, che proclama il suo spiritualismo con autorevolezza vagamente futurista nel taglio e nella posa, tra lo stentoreo e l’estatico, sempre nei toni freddi e severi del grigio e dell’azzurro. Dal vivo ha inizialmente creato un fondo levissimo con macchie d’azzurro acquerellate, poi ha iniziato a disegnarvi sopra, direttamente col pennello, una forma presto definita come un abbraccio in cui l’uomo, stringendo la donna, sembra sollevarla mentre la fa aderire a sé in una figurazione compatta che attraversa diagonalmente il quadro, con la dolcezza di un colore lieve, in un’atmosfera magari un po’ troppo “diluita” rispetto alle altre prove dell’artista, ma pure sempre meno esteticamente “faticose” rispetto a “Eppur mi infetto di te” in cui ha utilizzato una tecnica derivata da Burri come quella del collage di pezzi di sacchi di iuta per poi però dipingervi sopra, a fatica, vista l’immane ruvidezza del supporto, ancora il suo soggetto preferito, una donna stilizzata, tra grezza terrosità, il ventre nero, e sfumature tattili rossicce.
Marte Live contest, Giulia Fiaschetti con “Solo ciò che è necessario è pesante, solo ciò che pesa ha valore” non ha inteso esaltare i lottatori di sumo o quella ampia percentuale della popolazione americana che è decisamente sovrappeso e si cura con gli hot dogs al miele e senape; no, la Fiaschetti ha voluto affermare il pondus di una donna baciata dal gravame sferoidale d’una maternità che la fa rifulgere scultorea come un insieme di forme plumbee e metafisiche su uno sfondo nero, blu e rosso che si curva nell’ attesa del frutto di questa gravidanza. Quest’ultima sembra quasi una “concrètion” alla Hans Arp, un procedimento naturale basato su forme morbide che solo l’atto umano di dipingere o di partorire può indirizzare verso una forma specifica. E qui da questa solennità energetica e arcana non possiamo che attenderci la messa al mondo di una perfezione concentrica. “Assaporando la dolce leggerezza dell’essere”, l’artista invece contraddice Milan Kundera negando l’insostenibilità della medesima, affondandola piuttosto in una suggestiva aureola di luce in cui la stesura del colore è prodotta in qualche zona, da pennellate a spazzola incrociate, a sfumare, attorno alla figura monumentale, che proclama il suo spiritualismo con autorevolezza vagamente futurista nel taglio e nella posa, tra lo stentoreo e l’estatico, sempre nei toni freddi e severi del grigio e dell’azzurro. Dal vivo ha inizialmente creato un fondo levissimo con macchie d’azzurro acquerellate, poi ha iniziato a disegnarvi sopra, direttamente col pennello, una forma presto definita come un abbraccio in cui l’uomo, stringendo la donna, sembra sollevarla mentre la fa aderire a sé in una figurazione compatta che attraversa diagonalmente il quadro, con la dolcezza di un colore lieve, in un’atmosfera magari un po’ troppo “diluita” rispetto alle altre prove dell’artista, ma pure sempre meno esteticamente “faticose” rispetto a “Eppur mi infetto di te” in cui ha utilizzato una tecnica derivata da Burri come quella del collage di pezzi di sacchi di iuta per poi però dipingervi sopra, a fatica, vista l’immane ruvidezza del supporto, ancora il suo soggetto preferito, una donna stilizzata, tra grezza terrosità, il ventre nero, e sfumature tattili rossicce.
 Anna Carolina Lo Bosco ha portato nella sala pittura un trittico formato da tre tele verticali che contengono a stento delle ampie sfumature rosse e giallo paglia, un esercizio sul movimento e la fluidità delle masse di colore, qui granuloso ma caldissimo, in qualche modo segnato anche da una certa tridimensionalità dei vortici magmatici, grazie ad accenni di sfumature nere che spingono, volendo, su un piano psicanalitico que-sta proiezione incontrollabile di passionalità indifferenziata e pervasiva, effusione oceanica di piacere, ed infatti pare trattarsi – anche qui, come per la Fiaschetti – di due “pancioni” a confronto (una madre e una figlia entrambe madri?) in una simmetria verticale distesa, con la luce della vita che passa tra di loro suggellando un prossimo sboccio. Dal vivo ha prodotto un altro trittico, più piccolo, su tavola, su cui l’artista ha tracciato delle mani che si appoggiano su un tavolo, delle labbra automorsicate in un sensuale ammicca-mento, e delle palme di piedi, tutti dettagli destinati ad essere lavorati a grafite su un fondo monocromo, creato da grandi macchie di acrilico acquerellato, bruno con colori profondi ma spenti, su cui il disegno a grafite non “stacca”.
Anna Carolina Lo Bosco ha portato nella sala pittura un trittico formato da tre tele verticali che contengono a stento delle ampie sfumature rosse e giallo paglia, un esercizio sul movimento e la fluidità delle masse di colore, qui granuloso ma caldissimo, in qualche modo segnato anche da una certa tridimensionalità dei vortici magmatici, grazie ad accenni di sfumature nere che spingono, volendo, su un piano psicanalitico que-sta proiezione incontrollabile di passionalità indifferenziata e pervasiva, effusione oceanica di piacere, ed infatti pare trattarsi – anche qui, come per la Fiaschetti – di due “pancioni” a confronto (una madre e una figlia entrambe madri?) in una simmetria verticale distesa, con la luce della vita che passa tra di loro suggellando un prossimo sboccio. Dal vivo ha prodotto un altro trittico, più piccolo, su tavola, su cui l’artista ha tracciato delle mani che si appoggiano su un tavolo, delle labbra automorsicate in un sensuale ammicca-mento, e delle palme di piedi, tutti dettagli destinati ad essere lavorati a grafite su un fondo monocromo, creato da grandi macchie di acrilico acquerellato, bruno con colori profondi ma spenti, su cui il disegno a grafite non “stacca”.
Giorgia Lucci, già presente al MArteLive dello scorso anno, con le sue tele ad acrilico, strette e panoramiche,  propone immagini di scenari tropicali stilizzati: con “Il gufo” lascia che con accuratezza grafica i rami a tortiglione di una vegetazione selvaggia si comportino come il motivo ornamentale sul rosso a ghirigori lievi e sfumati dello sfondo, fino a fungere da sostegno per il rapace notturno, pop-fumettistico con l’espressione enigmatica e l’occhio sinistro alterato da qualche bacca dai poteri allucinogeni, mentre una deforme falce di luna si staglia, materica e porosa col suo colore sabbiato. In “L’Andrea” l’elemento sabbiato è il corpo alieno e nero della donna dai capelli rossi che protende un tentacolo fin quasi a sorreggere una sfera placentare – e ridalli!, è il filo conduttore della serata? – contenente forse embrioni, forse solo forme psichedeliche che lasciano una scia di arcobaleno, all’ora di un tramonto da mari del sud-est che la Lucci, memore della casa in cui ha vissuto parte della sua infanzia (se abbiamo capito bene nonostante la musica ad alto volume), contamina col suo senso femminile e decorativo del mistero e della ricchezza spirituale delle forme di vita, che però al contempo risente di una ingenuità ancora da contenere, in alcuni tratti. Dal vivo ha preferito lavorare ad acuerello perché è molto meticolosa e temeva con l’acrilico di non disporre del tempo sufficiente a definire l’immagine a cui voleva arrivare: quella di un buco della serratura senza nulla di morboso, ma inteso bensì come spazio limpido interiore in cui una lumaca curiosa impiega tempo prima di poter guardare, coi suoi buffi occhi in cima alle cornine estendibili, così come dopo aver costruito la fiducia in un rapporto, basta poco a far naufragare l’incanto. In questo caso la delicata visione del morbido spicchio di luna e del faro che è anche un naso sopra la bocca della spiaggia, si dissolve nel fondo verde da favola per anime candide.
propone immagini di scenari tropicali stilizzati: con “Il gufo” lascia che con accuratezza grafica i rami a tortiglione di una vegetazione selvaggia si comportino come il motivo ornamentale sul rosso a ghirigori lievi e sfumati dello sfondo, fino a fungere da sostegno per il rapace notturno, pop-fumettistico con l’espressione enigmatica e l’occhio sinistro alterato da qualche bacca dai poteri allucinogeni, mentre una deforme falce di luna si staglia, materica e porosa col suo colore sabbiato. In “L’Andrea” l’elemento sabbiato è il corpo alieno e nero della donna dai capelli rossi che protende un tentacolo fin quasi a sorreggere una sfera placentare – e ridalli!, è il filo conduttore della serata? – contenente forse embrioni, forse solo forme psichedeliche che lasciano una scia di arcobaleno, all’ora di un tramonto da mari del sud-est che la Lucci, memore della casa in cui ha vissuto parte della sua infanzia (se abbiamo capito bene nonostante la musica ad alto volume), contamina col suo senso femminile e decorativo del mistero e della ricchezza spirituale delle forme di vita, che però al contempo risente di una ingenuità ancora da contenere, in alcuni tratti. Dal vivo ha preferito lavorare ad acuerello perché è molto meticolosa e temeva con l’acrilico di non disporre del tempo sufficiente a definire l’immagine a cui voleva arrivare: quella di un buco della serratura senza nulla di morboso, ma inteso bensì come spazio limpido interiore in cui una lumaca curiosa impiega tempo prima di poter guardare, coi suoi buffi occhi in cima alle cornine estendibili, così come dopo aver costruito la fiducia in un rapporto, basta poco a far naufragare l’incanto. In questo caso la delicata visione del morbido spicchio di luna e del faro che è anche un naso sopra la bocca della spiaggia, si dissolve nel fondo verde da favola per anime candide.
 Lefkada (Leocadia Ammendola) ha portato al MArteLive un grande dipinto, “Il becco”, in cui con la cromìa ed il tratto nervoso di un pennello che lavora a tratti come se segnasse cicatrici insieme ai tratteggi, com-pone un’immagine che sarebbe astratta se non contenesse gli occhi gestuali, stilizzati e drammatici di una creatura espressionista che ha gli stessi colori accesi dell’esperienza dei fauve ma anche l’inquietudine ne-vrotica del movimento (soprattutto tedesco) dei primi decenni del novecento. Senza dimenticare di rilevare che a sinistra, il manico sporchissimo di un pennelletto, bucata la tela, pendeva da piccolo squarcio ponen-dosi come l’unico possibile becco della creatura, selvaggia, sofferta, esasperata e volutamente citrulla, ma solo per contrapporsi alla “cultura aulica”, s’intende! In “Caos cosmico”, il referente nella storia dell’Arte po-trebbe essere, così, a naso, Andrè Masson col suo energetico coinvolgimento di secrezioni materiche nello spazio fluido dell’opera, vedi le chine o gli esperimenti di “scrittura automatica” con colla, sabbia e olio, di soggetto fortemente erotico, tanto che non solo gli alti funzionari nazisti durante l’occu-pazione della Francia lo bollarono come “artista degenerato” ma anche alcuni ottusi ufficiali di dogana ame-ricani, al suo arrivo a New York, dove si rifugiò durante la guerra, sequestrarono alcuni suoi disegni distrug-gendoli sotto i suoi occhi! In quest’opera di Lefkada, un dripping primevo, accennato, si accompagna all’inserimento di corde, fil di ferro e calce, ad illustrare avventure della linea in uno spazio libero, un cosmo erratico in cui, se non ci fosse da salvaguardare l’interesse prosaico della sanità mentale ed erotica dei rivenditori di articoli di belle arti, ci si potrebbe perdere divertendosi, se provvisti solo delle mappe surrealiste della “reverie”! Dal vivo l’artista anarcoide si è prodotta con innumerevoli pennellate frenetiche su una composizione astratta e libera da troppi condizionamenti coscienti, che ricordava un delirio da sottobosco vissuto da un fringuello rimasto imprigionato tra i rovi, e frutto, stilisticamente, del pervertimento di un paesaggio di Cazanne ad opera di Oskar Kokoshka. Poi, però, imprevedibilmente, forse a causa dell’emergere inconsulto di una forma in torsione, nel contesto gestuale, l’artista ha “sbroccato” e ha iniziato a seppellire quanto aveva creato fino ad allora – “A me capita sempre così”, si giustificava – con schizzi abbondanti di biacca poi sparsi con le dita, verso una modulazione nuova, da raggiungere manualmente, lasciandosi guidare da uno squilibrio nervoso dei sensi, non come Kirchner, che usando l’io come soggetto sperimentale si procurò un disastroso esaurimento da assuefazione alla morfina, ma semplicemente usando il proprio impulso da pittrice “tormentata e vitale insieme” e per di più simpatica, a parte gli schizzi che irriguardosamente dalla sua tela arrivavano fin sull’acquerello della Giorgia Lucci!
Lefkada (Leocadia Ammendola) ha portato al MArteLive un grande dipinto, “Il becco”, in cui con la cromìa ed il tratto nervoso di un pennello che lavora a tratti come se segnasse cicatrici insieme ai tratteggi, com-pone un’immagine che sarebbe astratta se non contenesse gli occhi gestuali, stilizzati e drammatici di una creatura espressionista che ha gli stessi colori accesi dell’esperienza dei fauve ma anche l’inquietudine ne-vrotica del movimento (soprattutto tedesco) dei primi decenni del novecento. Senza dimenticare di rilevare che a sinistra, il manico sporchissimo di un pennelletto, bucata la tela, pendeva da piccolo squarcio ponen-dosi come l’unico possibile becco della creatura, selvaggia, sofferta, esasperata e volutamente citrulla, ma solo per contrapporsi alla “cultura aulica”, s’intende! In “Caos cosmico”, il referente nella storia dell’Arte po-trebbe essere, così, a naso, Andrè Masson col suo energetico coinvolgimento di secrezioni materiche nello spazio fluido dell’opera, vedi le chine o gli esperimenti di “scrittura automatica” con colla, sabbia e olio, di soggetto fortemente erotico, tanto che non solo gli alti funzionari nazisti durante l’occu-pazione della Francia lo bollarono come “artista degenerato” ma anche alcuni ottusi ufficiali di dogana ame-ricani, al suo arrivo a New York, dove si rifugiò durante la guerra, sequestrarono alcuni suoi disegni distrug-gendoli sotto i suoi occhi! In quest’opera di Lefkada, un dripping primevo, accennato, si accompagna all’inserimento di corde, fil di ferro e calce, ad illustrare avventure della linea in uno spazio libero, un cosmo erratico in cui, se non ci fosse da salvaguardare l’interesse prosaico della sanità mentale ed erotica dei rivenditori di articoli di belle arti, ci si potrebbe perdere divertendosi, se provvisti solo delle mappe surrealiste della “reverie”! Dal vivo l’artista anarcoide si è prodotta con innumerevoli pennellate frenetiche su una composizione astratta e libera da troppi condizionamenti coscienti, che ricordava un delirio da sottobosco vissuto da un fringuello rimasto imprigionato tra i rovi, e frutto, stilisticamente, del pervertimento di un paesaggio di Cazanne ad opera di Oskar Kokoshka. Poi, però, imprevedibilmente, forse a causa dell’emergere inconsulto di una forma in torsione, nel contesto gestuale, l’artista ha “sbroccato” e ha iniziato a seppellire quanto aveva creato fino ad allora – “A me capita sempre così”, si giustificava – con schizzi abbondanti di biacca poi sparsi con le dita, verso una modulazione nuova, da raggiungere manualmente, lasciandosi guidare da uno squilibrio nervoso dei sensi, non come Kirchner, che usando l’io come soggetto sperimentale si procurò un disastroso esaurimento da assuefazione alla morfina, ma semplicemente usando il proprio impulso da pittrice “tormentata e vitale insieme” e per di più simpatica, a parte gli schizzi che irriguardosamente dalla sua tela arrivavano fin sull’acquerello della Giorgia Lucci!
il7 – Marco Settembre
Foto di Fabio Ventrone
31 maggio, Anna Carolina Lo Bosco, Giorgia Lucci, Giulia Fiaschetti, Irene Salvatori, Lefkada (Leocadia Ammendola), Leocadia Ammendola, marco Settembre, Marco Settembre- Il_7, martelive 2011, pittura